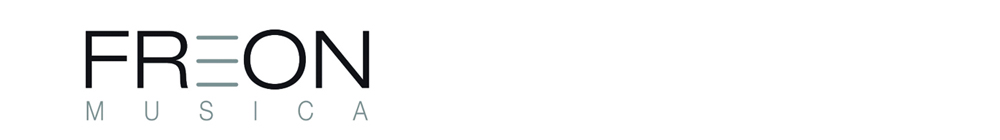Dieci poesie
(da Il bene materiale, Milano, Scheiwiller, 2008)
«Buongiorno, mi dia tre etti del cadavere
di un manzo. Però mi raccomando, che sia
di quello che non ha sofferto andando
al macello, del più sciocco, fidente o
soprappensiero, cui l’ultimo muggito
non abbia striato la carne d’incubo
e maledizione contro la nostra biblica
autorità, e autorizzazione. Un bel vitello
con la nervatura non ustionata
dalla memoria d’un cancello.
Che stia bene col brodo leggero,
la frutta di stagione e l’aroma
del vino novello. Mi dia di quello».
**
Welby
«A Dio» li sento quasi
dal mio letto «a Dio la vita
e la morte», in calma
ed errore. Ed io non so
le duecentoventi volts che ancora
mi accendono e l’ossigeno
di plastica inoculato
in questa mia immobilità
enorme, da quale cielo scendano.
Come il sole che all’alba è un uscire
dalla garitta e puntare il fucile
a impietrirmi sull’alt. E sì
che «addio» vorrei dir loro,
«addio» che tanto
meno sordo e roco
e poco più che umano
suona.
**
Paolo Malatesta (a parte, di Francesca)
«Aver bisogno, per parlare,
di un’altra poesia.
Dover piangere, nel vostro
purgatorio di corpi, il paradiso
d’un Libro sacro e scortese, nero
d’inchiostro. Nel mortorio
dei giorni stare sospesi, dannandosi
al vero infinito del desiato riso.
La mia bufera non è allegorica
e il quinto canto è una diceria.
Se avete un’anima, gettatela via».
**
La nuda
È distesa sognante nuda
fra le lenzuola smosse
in penombra mostra i seni
negligenti fra le dita come
chi rimanda e non disdice
l’appuntamento, aspetta
l’acquirente sospettoso
nel cartellone pubblicitario
in bianco e nero alla stazione.
«Allora?», dico, «Vuoi fare l’amore?
Sei distratta, accaldata,
sola e abbandonata?
Stai pensando “ne ho abbastanza”,
stai sognando chi non c’è
o la doccia e la tua stanza?».
«No», risponde, «non ho certo
l’intenzione, è più cruda
la faccenda, non che io
m’illuda che restino, tanto
artefatte, le mie bellezze
di attrezzista e truccatore,
ma se guardi un po’ più addentro
io do aspetto ad un cartone,
a partire dall’androne
sono ciò che benedice
il viaggiatore diario
cui la sveglia ha ionizzato
il sogno con l’assoluto
di un orario. Nell’alba
ancora nera e prima
della destinazione vera
io sono il viaggio premio
che dura fino al binario».
**
Prova a dormire con chi ti solletica
od alle due di notte accende il sole:
così l’inverno mite con le piante
che dure in balcone tenevano i tempi
alla nostra riservatezza spoglia,
ai mesi di sospetto e controvoglia,
alla nostra retta dissipazione.
Guarda: reggono a stento
alla provocazione, tornano quasi
alla rissa. Alterco primaverile
che nella nera estate poi si fissa.
**
Preghiera serale della moglie
«Tu inseguilo, domani. E appena
sulla sua strada invernale
s’avventerà solare l’aliante
di tutte le direzioni, chiudigli
i pugni sul volante, trascorra
in obbedienza la noia della via,
bagna – ma per un’ora – le sue parole
di cui si accende e accora
la mia incompiuta gelosia».
**
Non credere che il corpo ti appartenga:
l’insetto estivo basta a farne
milligrammi di spreco, quotidiano
il pane lo adesca; e allo specchio
stravedi il tempo all’opera
sul corpo di tua madre, ignori
meraviglie che in silenzio
accorano il marito, dei passanti
facendo nemici. Così
non credere nel corpo, sperdilo
nell’unione serale, nella nostra
altissima confusione, e dopo
vendilo al sonno nelle acque notturne.
**
Tempo reale
Mia moglie è dal suo parrucchiere
seduta allo specchio, sotto mani
guantate in lattice che intrecciano
e sciolgono la scena della corta
capigliatura. Come labili punte
di lancia i capelli inumiditi
le segnano una tempia o si alzano
in cresta prima che il pettine
li rimetta all’ordine e all’età.
Lei increspa la fronte, accentra
le pupille cerchiate di neon,
si scruta: «Oh se la fine –
pensa, e non è più distratta –
fosse il mutamento di un’ora,
lo spezzare calcolato di un capello
e non questo svanire presunto
inosservabile, questa lavatura
delicata e infame. Fosse uno squillo
solenne, una catastrofe precisa
cui ci si rechi come a scadere».
Poi s’alza, in piega asciutta,
paga silenziosa, esce in strada
ed il cammino la riporta rapida.
Sento la chiave nella porta,
il passo chiaro, appena disperso,
che stringe ormai la penna all’ultimo verso.
**
La piazza
La piazza è sempre dal vivo
anche quando la vedi deserta;
è chiusa perché sembra aperta,
è un vicolo cieco malato d’ipertrofia:
è il vero anagramma della pazzia.
Se grandi, le piazze danno cattive idee
a uomini corrucciati e solitari;
le piazze sono tanti mari
coi passi umani come maree.
La piazza è il sogno di molti
che confluisce nella storia,
soccorre chi ha poca memoria
e scorda il nome in prosa della via;
è un meccanismo ad orologeria
che nella folla ripete un’eternità.
Ladra di tempo, la piazza non fa
ciò che saprebbe, o dovrebbe sapere;
è una cambiale firmata al dovere
che prima o poi la riscuoterà.
Largo, Scalo, Spiazzo o Belvedere
la piazza è un secolo rimasto in posa:
se nella via pensi al tempo a vedere
stai nella piazza chiedendoti cosa.
**
Non è meno infinita del mare
la roccia, con il suo non parlare
tetro, materia delusa, implosa,
nel suo sgretolarsi, una rosa.
Paolo Febbraro
Dieci poesie
(da Il bene materiale, Milano, Scheiwiller, 2008)
«Buongiorno, mi dia tre etti del cadavere
di un manzo. Però mi raccomando, che sia
di quello che non ha sofferto andando
al macello, del più sciocco, fidente o
soprappensiero, cui l’ultimo muggito
non abbia striato la carne d’incubo
e maledizione contro la nostra biblica
autorità, e autorizzazione. Un bel vitello
con la nervatura non ustionata
dalla memoria d’un cancello.
Che stia bene col brodo leggero,
la frutta di stagione e l’aroma
del vino novello. Mi dia di quello».
Welby
«A Dio» li sento quasi
dal mio letto «a Dio la vita
e la morte», in calma
ed errore. Ed io non so
le duecentoventi volts che ancora
mi accendono e l’ossigeno
di plastica inoculato
in questa mia immobilità
enorme, da quale cielo scendano.
Come il sole che all’alba è un uscire
dalla garitta e puntare il fucile
a impietrirmi sull’alt. E sì
che «addio» vorrei dir loro,
«addio» che tanto
meno sordo e roco
e poco più che umano
suona.
Paolo Malatesta (a parte, di Francesca)
«Aver bisogno, per parlare,
di un’altra poesia.
Dover piangere, nel vostro
purgatorio di corpi, il paradiso
d’un Libro sacro e scortese, nero
d’inchiostro. Nel mortorio
dei giorni stare sospesi, dannandosi
al vero infinito del desiato riso.
La mia bufera non è allegorica
e il quinto canto è una diceria.
Se avete un’anima, gettatela via».
La nuda
È distesa sognante nuda
fra le lenzuola smosse
in penombra mostra i seni
negligenti fra le dita come
chi rimanda e non disdice
l’appuntamento, aspetta
l’acquirente sospettoso
nel cartellone pubblicitario
in bianco e nero alla stazione.
«Allora?», dico, «Vuoi fare l’amore?
Sei distratta, accaldata,
sola e abbandonata?
Stai pensando “ne ho abbastanza”,
stai sognando chi non c’è
o la doccia e la tua stanza?».
«No», risponde, «non ho certo
l’intenzione, è più cruda
la faccenda, non che io
m’illuda che restino, tanto
artefatte, le mie bellezze
di attrezzista e truccatore,
ma se guardi un po’ più addentro
io do aspetto ad un cartone,
a partire dall’androne
sono ciò che benedice
il viaggiatore diario
cui la sveglia ha ionizzato
il sogno con l’assoluto
di un orario. Nell’alba
ancora nera e prima
della destinazione vera
io sono il viaggio premio
che dura fino al binario».
Prova a dormire con chi ti solletica
od alle due di notte accende il sole:
così l’inverno mite con le piante
che dure in balcone tenevano i tempi
alla nostra riservatezza spoglia,
ai mesi di sospetto e controvoglia,
alla nostra retta dissipazione.
Guarda: reggono a stento
alla provocazione, tornano quasi
alla rissa. Alterco primaverile
che nella nera estate poi si fissa.
Preghiera serale della moglie
«Tu inseguilo, domani. E appena
sulla sua strada invernale
s’avventerà solare l’aliante
di tutte le direzioni, chiudigli
i pugni sul volante, trascorra
in obbedienza la noia della via,
bagna – ma per un’ora – le sue parole
di cui si accende e accora
la mia incompiuta gelosia».
Non credere che il corpo ti appartenga:
l’insetto estivo basta a farne
milligrammi di spreco, quotidiano
il pane lo adesca; e allo specchio
stravedi il tempo all’opera
sul corpo di tua madre, ignori
meraviglie che in silenzio
accorano il marito, dei passanti
facendo nemici. Così
non credere nel corpo, sperdilo
nell’unione serale, nella nostra
altissima confusione, e dopo
vendilo al sonno nelle acque notturne.
Tempo reale
Mia moglie è dal suo parrucchiere
seduta allo specchio, sotto mani
guantate in lattice che intrecciano
e sciolgono la scena della corta
capigliatura. Come labili punte
di lancia i capelli inumiditi
le segnano una tempia o si alzano
in cresta prima che il pettine
li rimetta all’ordine e all’età.
Lei increspa la fronte, accentra
le pupille cerchiate di neon,
si scruta: «Oh se la fine –
pensa, e non è più distratta –
fosse il mutamento di un’ora,
lo spezzare calcolato di un capello
e non questo svanire presunto
inosservabile, questa lavatura
delicata e infame. Fosse uno squillo
solenne, una catastrofe precisa
cui ci si rechi come a scadere».
Poi s’alza, in piega asciutta,
paga silenziosa, esce in strada
ed il cammino la riporta rapida.
Sento la chiave nella porta,
il passo chiaro, appena disperso,
che stringe ormai la penna all’ultimo verso.
La piazza
La piazza è sempre dal vivo
anche quando la vedi deserta;
è chiusa perché sembra aperta,
è un vicolo cieco malato d’ipertrofia:
è il vero anagramma della pazzia.
Se grandi, le piazze danno cattive idee
a uomini corrucciati e solitari;
le piazze sono tanti mari
coi passi umani come maree.
La piazza è il sogno di molti
che confluisce nella storia,
soccorre chi ha poca memoria
e scorda il nome in prosa della via;
è un meccanismo ad orologeria
che nella folla ripete un’eternità.
Ladra di tempo, la piazza non fa
ciò che saprebbe, o dovrebbe sapere;
è una cambiale firmata al dovere
che prima o poi la riscuoterà.
Largo, Scalo, Spiazzo o Belvedere
la piazza è un secolo rimasto in posa:
se nella via pensi al tempo a vedere
stai nella piazza chiedendoti cosa.
Non è meno infinita del mare
la roccia, con il suo non parlare
tetro, materia delusa, implosa,
nel suo sgretolarsi, una rosa.